Il flagello della guerra nel tardo medioevo in Canavese si incarnò anche nel famoso condottiero Bonifacio (Faci-no) Cane. Nato forse a Casale Monferrato tra il 1350 e il 1360 (altri dicono Caresana, altri ancora al castello di Vettigne nei pressi di Santhià) era figlio di Emanuele Cane di Casale di Sant’Evasio. Di umili origini, intraprese giovane il mestiere delle armi combattendo nel napoletano agli ordini di Ottone di Brunswich. Lo seguirono i fratelli, Filippino e Marcolo.
Al soldo di Verona in guerra contro Padova, fu preso prigioniero e meditando sulla natura della guerra legata agli interessi economici dei potentati cittadini e signorili, passò al servizio di Padova e per quei signori scatenò la sua ferocia in Friuli e partecipò al sacco di Aquileia del 3 aprile 1387. Nel 1391 tornò al servizio del marchese di Monferrato, salvo passare l’anno dopo ai Visconti ma per poi tornare ai Monferrato nel 1393. Nel 1396 mise i quartieri militari in Canavese, Nel settembre 1397 tornò alle armi viscontee contro Mantova.
Nel 1399 con Teodoro del Monferrato entrò in guerra contro i Savoia e la sua carriera, stroncata solo dalla morte, giunse rapidamente all’apice: nel 1401 passò ai Visconti e dopo un’incredibile serie di successi militari nel 1409 mise le mani sul governo del ducato di Milano. Nel 1410 prese Pavia e la mise a sacco. Nel 1412 si ammalò durante la campagna della bergamasca e morì a Pavia il 16 maggio.
Dal 1391 iniziò a intermittenza un lungo periodo impiegato a molestare le terre degli Acaia e dei Savoia. Apparve già nel 1387 ai confini orientali del Canavese, segnalato ad Amedeo VII di Savoia dal castellano di Santhià. Le mire sabaude, bloccate in Francia, puntavano sul Piemonte, un po’ in sordina, un po’ in alleanza con i Visconti padroni della Lombardia. Il contrasto esplose quando Milano volle il controllo di Ivrea, importante nodo per il commercio del sale, delle mole, degli utensili di ferro e dei cavalli. Saluzzo e Monferrato allora si schierano con Milano.
Inoltre nel 1386 era scoppiata la grande rivolta antiaristocratica dei Tuchini, soprattutto antisabauda. Divisi in piccoli drappelli e sfruttando al massimo la propria autonomia e mobilità, i mercenari di Facino Cane divennero una grossa spina nel fianco dello schieramento savoino lungo la direttrice Biella, Ivrea, Masino, Chi-vasso. Con le spalle coperte dalle amiche terre viscontee ad est, controllavano le truppe ammassate a Ivrea dai Savoia.
Il suo triangolo operativo aveva ai vertici Carisio, Masino e Azeglio intercettando e controllano la viaria già di epoca romana Eporedia–Vercellae. Uccisioni, assalti proditori, agguati e altre azioni criminose a danno delle popolazioni, davano il segno della sua presenza. Con i Tuchini si alleò per assalire e depredare Albiano di Ivrea, sede del castello del vescovo di Ivrea. Ma non attesero le truppe di Ivrea e si diedero alla fuga.
Tornò nel 1391 con la morte del Conte Rosso Amedeo VII per approfittare del vuoto di potere: il 29 novembre si concentrò nel contado di Azeglio per poi prendere paese e castello il 10 dicembre, appoggiato dai Ponzoni, gli estromessi signori del luogo. Poi l’orda mercenaria si scagliò su Cossano che venne presa per diventare base operativa per le razzie dei borghi in sponda sinistra della Dora Baltea. A San Martino Canavese razziò bestiame e uomini.
Assaltarono e distrussero il castello di Settimo Rottaro, saccheggiarono Caravino e ancora Azeglio. Fallirono a San Giorgio, ma devastarono Roppolo. La psicosi in Canavese era al massimo: il sanguinario mercenario fu paragonato ad un demone. Sapeva combattere all’attacco e in più punti quasi in simultanea rendendo impossibile il controllo savoino del territorio. Si unì l’anno nuovo con le bande di Ramazzotto della Mella e Brunone Guttuario, pagate per tenere in stato di guerra il Savoia. La situazione nei documenti dell’epoca, è conosciuta come la “Guerra di Azeglio”. Facino rientrò nel milanese e i Savoia schierarono una forza imponente per cacciare i Ponzoni e la piccola armata di Facino da Azeglio. Le trattative che porteranno alla “Pace di Azeglio” si tennero a Pavia, ma durò poco.
Agli inizi del 1393 Monferrato assoldò bande a tutto spiano contro i Savoia. I mercenari di Facino da più di un anno erano stanziati a Cossano e Azeglio. Da Chambery i Savoia aumentarono la rete di spie in Canavese, ma gli uomini di Facino Cane devastavano le campagne di Ivrea, distrussero la bastita eretta dai savoini davanti a Cossano per controllare il borgo. I savoini assediarono Settimo Rottaro ma non a scalarne le mura. Gian Galeazzo Visconti lasciò libero dalla condotta Facino Cane intorno a metà novembre e, all’inizio del 1394 attaccò Ivrea.
In accordo con i Masino, riunì la sua banda a quella di Ottone Rusca a Caluso e mossero su Ivrea da est, penetrano all’altezza dell’attuale corso Vercelli, il 16 febbraio. Bottino: 170 buoi razziati e 7 morti. Ritentarono invano un secondo attacco. Nel timore che la città venisse presa, 400 tra donne e bambini si rifugiarono nel castello. Intanto la furia di Facino si abbattè su Vestignè e Palazzo. Borgomasino sembrava dover cadere in mano ai faciniani che ogni giorno assaltavano le mura.
Poi scese una relativa tregua mentre risalì la tensione tra Acaia e Monferrato anche se il Canavese restò stabilmente infestato da ben 6 bande mercenarie. Facino tornò con le sue scorrerie nel 1399 e attaccò Rivarolo, San Maurizio, Ciriè, Lanzo, Settimo Rottaro, Caravino e Ivrea. Carisio occupata fu una nuova base di Facino Cane e da qui la sua ferocia rese inabitabile Occhieppo Inferiore. Il 28 febbraio assaltò le mura di Settimo Rottaro e prese la rocca che fu incendiata: perirono i nobili Sicco, i loro vassalli e i contadini. La strage fu tale che dei loro nomi non vi fu più traccia nei documenti successivi. Il 1° marzo toccò a Caravino ove sorse nei pressi un vero e proprio campo di concentramento per prigionieri.
Dopo aver tolto di mezzo gli Acaia, dietro alla furia di Facino si palesarono gli intenti di Teodoro II di Monferrato e di Gian Galeazzo Visconti decisi a battere i Savoia. Però davanti a Facino Cane si stagliò allora il miglior condottiero dei Savoia: Ibleto di Challant incaricato per iscritto di spazzare via il condottiero. Ma intanto cadde sotto le insegne del cane ringhiante Castiglione Torinese nello sconcerto di tutto il Canavese. Lo scontro aperto avvenne a Caravino l’8 luglio: la schiera savoina contava su compattezza e massa d’urto, tamburi rullanti e bandiere al vento con circa 800 uomini d’arme e armi da fuoco.
Il primo urto fu loro favorevole e i faciniani, circa un migliaio, combattevano in piccoli drappelli che vennero respinti e poi dispersi in fuga. Nel contempo un gruppo di soldati penetrò nella roccaforte faciniana appiccandovi un vasto incendio. La battaglia fu vinta sul campo, ma nel ritorno a Ivrea, senza applicare le più elementari azioni di difesa fiancheggiante, la colonna fu assalita pesantemente dagli uomini di Facino Cane e catturata. Furono condotti in catene a Caravino e Settimo Rottaro circa 600 uomini con i due marescialli di campo sabaudi, Rodolfo di Gruyere e Giovanni Verney, Galeazzo di Mantova, Amedeo di Challant e il conte Ugo, cioè l’intero stato maggiore sabaudo.
Facino Cane assediò nuovamente Ivrea ma Pietro Bertodano, poi creato conte palatino per le sue gesta, seppe infiammare gli eporediesi che resistettero agli assalti e poi contrastarono fuori le mura i faciniani fino a metterli in fuga sulla Serra, scacciandoli da Mongrando e da Gaglianico. Infuriava anche la peste, che risparmiò Ivrea, e furoreggiava il brigantaggio nelle campagne.
Facino Cane attaccò Barbania mentre Rivara gli resistette, attaccò e prese Castellamonte, malgrado le trattative di pace in corso tra Savoia, Visconti, Monferrato e Acaia. Sembrava agire autonomamente e accettò la proposta savoina di liberare Carisio, Settimo Rottaro e Caravino per danaro. Ibleto di Challant accettò la richiesta di 7000 genovine d’oro. Ma mentre la somma veniva raccolta, attaccò e distrusse centri nel Vercellese, attaccò Lanzo e ancora Ivrea, in estate poi attaccò Cigliano catturando numerosi abitanti. Fu l’ultima impresa canavesana. Il 23 marzo 1402 i tre borghi e castelli faciniani rientrarono in possesso sabaudo e il condottiero ormai nell’orbita del ducato di Milano.
La sua fama conobbe anche insoliti risvolti popolari tra Otto e Novecento: Honoré de Balzac scrisse una novella, Facino Cane, pubblicata nel 1837 nella raccolta Commedia Umana, in cui il protagonista, discendente dell’omonimo condottiero, è un personaggio criminale del XVIII secolo attratto dall’oro. La sua storia illustrata apparve invece nelle figurine della Liebig nel 1911, sempre in francese. In Canavese negli Anni ’80 del Novecento campeggiava sulle etichette delle bottiglie di Erbaluce di Caluso imbottigliato dal dottor Corrado Gnavi.
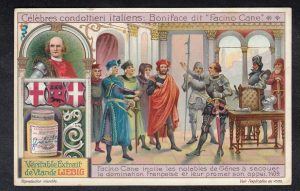
Facino Cane nelle figurine Liebig



