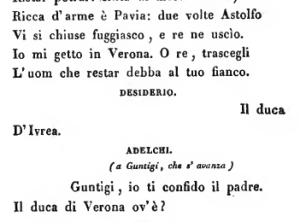Foto: Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Manzoniana: ritratto di Alessandro Manzoni (olio su tela realizzato nel 1835 da Giuseppe Molteni; il paesaggio sullo sfondo con una
veduta di Lecco è opera di Massimo d’Azeglio)
Oltre ai numerosi documenti storici che possono far luce sulla fase di passaggio dall’Ivrea longobarda a quella carolingia esistono anche quelli letterari. Tra di essi la tragedia Adelchi di Alessandro Manzoni rappresenta il più autorevole e interessante, non soltanto per la qualità artistica.
Com’è noto, Manzoni pubblicò il suo dramma per l’editore Vincenzo Ferrario (Milano 1822), accompagnandolo con un Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia, collocato in calce al testo poetico.
Ma lo scrupolo storiografico dell’autore non si espresse soltanto con quell’elegante e, in alcuni punti, ironico libello: la tragedia è infatti preceduta da una quindicina di pagine di Notizie storiche (distinte in “Fatti anteriori all’azione compresa nella tragedia” e “Fatti compresi nell’azione della tragedia”), oltre che da cinque pagine di Costumanze caratteristiche alle quali si allude nella tragedia; insomma, un articolato compendio di ricerche e di riflessioni filologico-erudite che arricchiscono il contesto narrativo e giustificano numerose scelte dell’autore sul piano storico.
Ambientata tra gli anni 772-774, Adelchi è la storia della disfatta dei Longobardi di Desiderio e di suo figlio Adelchi, sconfitti dai Franchi di Carlo (il futuro Carlo Magno).
Al di là della vicenda, è il secondo esperimento manzoniano di “tragedia cristiana”, dopo l’esordio con Il Conte di Carmagola (1820). Con l’evidente proposito di enfatizzare l’effetto teatrale delle relazioni politiche tra i vari personaggi, Manzoni insiste sul tema del tradimento di alcuni Longobardi, o meglio sulla loro mancata fedeltà, avvalorando una notizia trasmessa esclusivamente dall’anonimo Chronicon Salernitanum (Cap. 9: Sed dum iniqua cupiditate Langobardi inter se consurgerent, quidem enim e proceribus Lango-bardis clam legationem mittunt Karolo, Francorum regi, quatenus veniret cum valido exercitu et regnum Italiae sub sua ditione obtineret, tradotto praticamente alla lettera dallo stesso Manzoni nella parte introduttiva: “In quel torno di tempo, essendo i Longobardi divisi di voleri e di parti, alcuni dei primati tennero pratica con Carlo, l’invitarono per messi a scendere in Italia con forte esercito, e ad impadronirsi del regno, promettendogli di dargli in mano Desiderio e le sue ricchezze”).
Sia nelle Notizie storiche sia nel Discorso il narratore argomenta la bontà di tale notizia, su cui si basa a tutti gli effetti l’azione del III e del IV Atto della tragedia. Ed è appunto il Duca di Ivrea, Guntigi, il principale responsabile del tradimento, o meglio della mancata “fedeltà” a Desiderio.
Tale Guntigi non può essere ricondotto ad alcuna corrispondenza storica precisa: anche il suo nome è invenzione manzoniana, basata su parallelismi onomastici delle fonti, al pari degli altri duchi che compaiono nella tragedia (Ilde-chi, Indolfo, Farvaldo, Ervigo). La plausibilità della sovrapposizione tra il “tipo” del traditore e la figura funzionale del duca di Ivrea è tutta geografica: Manzoni immagina che, dopo essere riusciti a sfondare le Chiuse d’Italia presso Susa, molto probabilmente i Franchi si siano diretti verso il più vicino e importante ducato, ossia quello di Ivrea, e lo abbiano occupato, sottraendolo al controllo del suo signore longobardo.
Nella scena IX del III Atto, quando Adelchi progetta la difesa di Pavia e di Verona dopo la disfatta di Susa, è lo stesso Desiderio a scegliere il Duca d’Ivrea, scacciato dal suo territorio, quale più fidato vassallo. Ed è per questo che a Pavia il re dei Franchi invia segretamente l’oscuro soldato Svarto, il traditore per eccellenza, a sobillare Guntigi, già incerto e vacillante sul futuro dei Longobardi.
Prima di discorrere con l’emissario di Carlo, Guntigi pronuncia un lungo monologo sulla fedeltà politica (IV), confessando di aver già deciso di abbandonare il regno longobardo e di passare al servizio dei Franchi, ormai vittoriosi ovunque.
Nella parte centrale e finale di questo lungo intervento, Guntigi si rivolge polemicamente agli assertori della fedeltà politica, nel tentativo di convincerli che hanno torto. Secondo Gun-tigi, infatti, i censori della morale agiscono sotto la spinta dell’ipocrisia e della malvagità, preferendo nutrire pietà per i fedeli (sconfitti) che non invidia per i traditori (vittoriosi). “Certo, se a voi consiglio | chieder dovessi, dir m’udrei: rigetta | l’offerte indegne; de’ tuoi re dividi, | qual ch’ella sia, la sorte. – E perchè tanto | a cor questo vi sta? Perché, s’io cado, | io vi farò pietà; ma se, tra mezzo | alle rovine altrui, ritto io rimango, | se cavalcar voi mi vedrete al fianco | del vincitor che mi sorrida, allora | forse invidia farovvi; e più v’aggrada | sentir pietà che invidia. Ah! non è puro | questo vostro consiglio”.
La meschina ed egoista morale di Guntigi, pertanto, costituisce in termini individuali la base del fenomeno politico di integrazione dei gruppi aristocratico-militari del regno longobardo in quello franco: un fenomeno che Manzoni rilegge in chiave nazionale, come costante oppressione degli abitanti italici da parte di dominatori stranieri (ora longobardi ora franchi). È, naturalmente, il tema del celebre primo Coro della tragedia, “Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti”, posto a conclusione del III Atto (ossia, subito dopo la scena in cui Desiderio decide di affidare la protezione di Pavia e di se stesso a Guntigi).
L’opportunista vassallo longobardo non è certo una figura di primo piano nella tragedia di Manzoni, offuscato com’è dalle presenze di Adelchi, Desiderio, Ermengarda, Carlo, Anfrido, il diacono Martino … Eppure, nello sviluppo drammaturgico della narrazione, il ruolo del duca di Ivrea è essenziale per comprendere la katastrophé della tragedia. Allorché Svarto lo raggiunge sugli spalti di Pavia assediata, Guntigi non gli nasconde l’amarezza per il fatto che Ivrea sia stata ceduta ad altri (“Ei prese | la mia cittade, e ne fe’ dono altrui; | né resta a me che un titol vano”, IV iv). Svarto lo rassicura immediatamente, spiegandogli che il torto subìto (il non essere stato integrato immediatamente nel sistema di potere franco) fa parte della strategia, il cui fine è che tutti credano Guntigi un nemico implacabile di Carlo.
Al contrario, il re dei Franchi ha già stabilito per lui ben altra ricompensa, se farà in modo di aprire le porte di Pavia e consegnargli il vecchio re Desiderio (“Carlo a’ tuoi pari dona | e non promette: Ivrea perdesti; il Conte, | prendi, (gli porge un diploma) sei di Pavia”). A partire da questo momento, la parola e l’azione di Guntigi non nutrono più alcun dubbio e si consegnano interamente alla causa di Carlo. Perdendo qualunque scrupolo, il carattere cessa di risultare interessante e scompare dall’intreccio, non prima però di un’ultima doppia esternazione.
1) La viltà: Guntigi chiede a Svarto di sottrarsi all’obbligo di consegnare personalmente il suo re, fatto prigioniero, al re dei Franchi (“Ch’io, preso | il re consegni al suo nemico, questo | Carlo da me non chieda; io fui vassallo | di Desiderio, in dì felici; e il mio | nome d’inutil macchia io coprirei”).
2) La propaganda servile: la nuova agenda politica di Guntigi è sorretta da un lessico degno del peggior machiavellismo (giacché i Longobardi sono, a suo dire, “Stanchi e sfidati i più, sotto il vessillo | stanno sol per costume: a lor consiglia | ogni pensier di abbandonar cui Dio | già da gran tempo abbandonò; ma in capo | d’ogni pensier s’affaccia una parola | che gli spaventa: tradimento. Un’altra | più saggia a questi udir farò: salvezza | del regno; e nostri diverran: già il sono”).
Guntigi non è né malvagio né vendicativo; pur essendo un traditore, responsabile della disgrazia definitiva di Desiderio e di Adelchi, gli interventi che Manzoni pone sulla sua bocca non sono diabolici né ambigui. Egli è rappresentazione della viltà, apparentemente complessa appunto perché priva delle caratteristiche convenzionali di un antagonista drammatico.
Il suo ritratto si comprende soltanto in funzione dell’economia della “tragedia”, come intuì quasi un secolo fa un ottimo interprete del teatro manzoniano (a sua volta esperto uomo di teatro), Onorato Castellino: “Non è […] una torbida passione quella che induce Guntigi al tradimento, e non è mai grande, neppure nel male, la sua figura di traditore ragionato ed oscuro. Per questo si perde nella più vasta risonanza della tragedia la viltà del suo gesto che più nessuno ricorda e nessuno incolpa: poiché la fine dei Longobardi era già segnata dal volere della Provvidenza prima che il tradimento di Guntigi aprisse a re Carlo le porte di Pavia” (SEI, Torino 1934, p. 126). Forse anche per questo il ricordo di Ivrea longobarda si è affievolito, mentre si imponeva quello, foriero di assai più importanti sviluppi, di Ivrea carolingia.