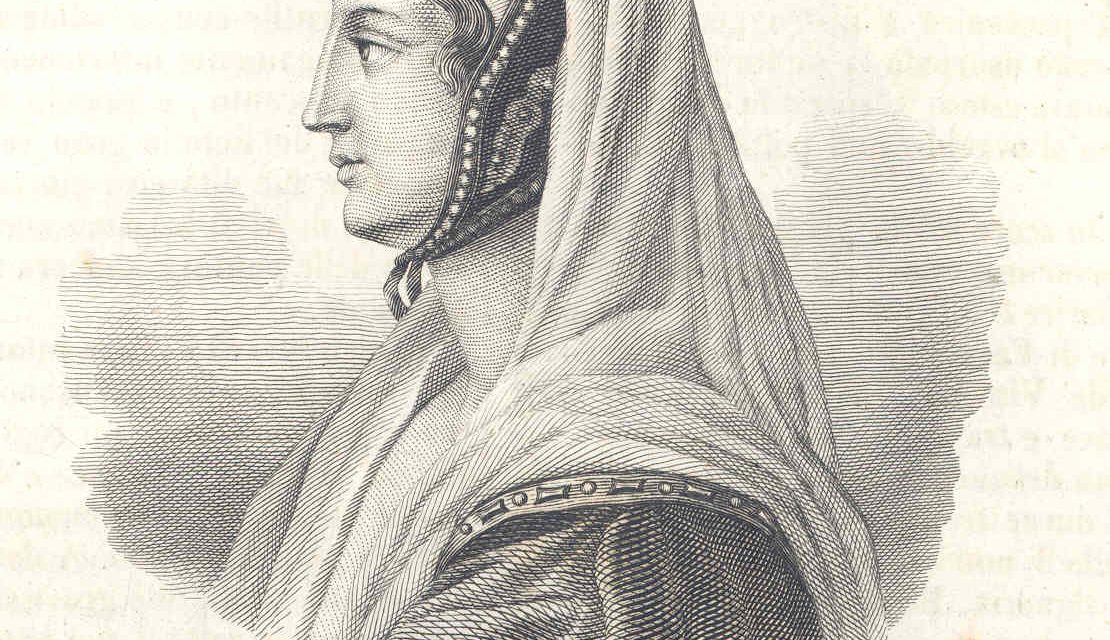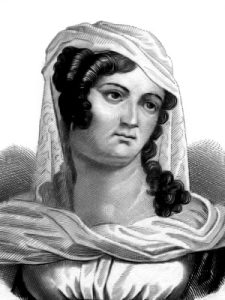Foto: Beatrice Cane in un ritratto d’invenzione dell’Ottocento.
Lo scorso 9 gennaio su “Il Risveglio Popolare” mi ero occupato di Facino Cane e delle sue tristi imprese belliche in Canavese, proponendo una tipica figura di condottiero della fine del Trecento. In questa occasione scriverò di sua moglie Beatrice, vissuta in un periodo in cui la figura femminile era relegata men che meno in secondo piano, e che ha rappresentato nella fortuna e nella sfortuna, la figura di una donna che fu potente, ma che per il potere perdette la testa. La sua storia ispirò Vincenzo Bellini nell’opera lirica “Beatrice di Tenda”.
L’’opera, su libretto di Felice Romani, debuttò al Teatro La Fenice di Venezia il 16 marzo 1833 ma ebbe un’accoglienza tiepida, rientrando a pieno titolo nel suo repertorio migliore, solo con il passare del tempo: l’ultimo importante allestimento è stato realizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova lo scorso anno. Ma veniamo alla nostra storia: Beatrice era nata a Tenda nel 1372, territorio passato dal Piemonte alla Francia alla fine della Seconda guerra mondiale. Era figlia del condottiero e poi diplomatico Ruggero Cane di Casale Monferrato, uomo di fiducia dei Visconti di Milano, sia di Bernabò che poi di Gian Galeazzo. La madre era Giacobina della nobile famiglia degli Asinari di Asti.
Ruggero, parente di Facino Cane, gli diede in sposa la figlia nel 1398 e lei spesso seguì il marito in guerra, diventando popolare nella milizia privata di Facino, o molto più probabilmente, buona amministratrice del soldo e coraggiosa sul campo di battaglia. Seguendo la carriera sanguinaria del marito – anche denominato dalle nostre parti “il flagello del Canavese” nelle guerre e guerriglie contro i Savoia per conto dei Monferrato – alla morte del marito, avvenuta il 16 maggio a Pavia dopo essere caduto ammalato nella campagna militare nella Bergamasca, Beatrice si trovò de facto a capo di un esercito agguerrito e con ingenti ricchezze.
Infatti Facino Cane aveva previsto tutto. Aveva scalato il potere del Ducato di Milano fin dal 1402, quando ottenute 7000 genovine di riscatto dai Savoia il 16 marzo, per lasciare i suoi capisaldi di Settimo Rottaro, Carisio e Caravino, e quindi definitivamente il Canavese. Con la morte per peste il 3 settembre del duca Gian Galeazzo Visconti, Facino si proiettò nel controllo del Ducato di Milano. Nel 1403 sottomise Bologna alla signoria Viscontea ottenendone il governo personale. Il suo dominio territoriale, tra il 1404 e il 1411, comprendeva, oltre ad alcuni ex-territori sabaudi, città importanti, come Alessandria, Novara, Varese, Tortona, Biandrate, parte del territorio della Brianza, Piacenza, Cantù, Melegnano e Pavia.
Alla sua morte, Beatrice avrebbe ereditato tutto quanto se si fosse sposata con il Duca di Milano Filippo Maria Visconti, più giovane di lei di circa vent’anni. Temuta quanto ambita, il matrimonio fu celebrato nel 1412 e Beatrice divenne Duchessa consorte di Milano. Ma i rapporti burrascosi e le ingerenze di Beatrice nel governo, portarono ad un tragico epilogo: nel 1418, probabilmente allo scopo di sottrarle gli ingenti possedimenti, fu accusata dal marito di adulterio con un domestico, tale Michele Orombelli.
Secondo alcuni, il piano fu ordito con la complicità della nobildonna Agnese del Maino, dama di compagnia di Beatrice e amante del marito. La donna in effetti diede le uniche figlie al duca: Bianca Maria Visconti (1425-1468), ultima Visconti milanese e sposa di Francesco Sforza, primo duca Sforza del ducato di Milano e Caterina Maria, che morì pochi giorni dopo la nascita (1426). Quindi Beatrice fu accusata di adulterio, un classico per sbarazzarsi di mogli invadenti nell’antichità e fu rinchiusa nel castello di Binasco. Qui confessò ovviamente sotto tortura e fu decapitata il 13 settembre 1418 senza processo. Svariate le tradizioni popolari su quei tristi eventi che vennero tramandati di generazione in generazione.
Quattro secoli dopo, nel 1823 la scrittrice torinese Diodata Saluzzo Roero, “madre” del romanzo gotico italiano, scrisse sulla vicenda della povera Beatrice “Il Castello di Binasco, Novella inedita” e due anni dopo lo scrittore cremonese Carlo Tedaldi Fores, incline a Ossian e al gotico, scrisse “Beatrice di Tenda” che ebbe un’accoglienza clamorosa per le polemiche e il successo di vendite. Il successo della storia della triste vicenda aveva acceso le passioni romantiche del pubblico. Cominciò a lavorarci lo scrittore e prolifico librettista d’opera Felice Romani, sollecitato un po’ troppo dal Bellini a fare in fretta, tanto che con quest’opera, i due litigarono e fu l’ultimo lavoro portato in scena dal grande musicista d’opera e dal suo librettista.
Ecco la trama del lavoro di Felice Romani:
Atto I. L’azione ha luogo nel 1418 al castello di Binasco, presso Milano. Filippo Maria Visconti, duca di Milano, è insofferente alla presenza della consorte, Beatrice de’ Lascari nonché contessa di Tenda, già vedova di Facino Cane. Beatrice ha portato in dote a Filippo molte terre, permettendogli di rafforzare il ducato, ma proprio queste terre sono diventate motivo di discordia tra i coniugi. Beatrice è infatti sensibile ai destini dei suoi sudditi, che Filippo tratta invece con estrema durezza. Agnese del Maino, amante di Filippo e innamorata di Orombello, signore di Ventimiglia, quando scopre che quest’ultimo è segretamente innamorato di Beatrice, decide di vendicarsi mettendo Filippo al corrente del presunto tradimento di Beatrice con Orombello. Questi dal canto suo, dopo aver adunato gli uomini devoti a Facino Cane per una riscossa contro l’ostile Filippo, si reca dall’afflitta Beatrice per dichiararle apertamente i propri progetti e il proprio amore. Agnese e Filippo irrompono in scena e vedendo Orombello inginocchiato ai piedi di Beatrice, interpretano il gesto come prova certa del tradimento e del complotto della duchessa.
Atto II. Durante il processo, Orombello ritratta le false accuse che Filippo gli ha estorto attraverso la tortura, proclamando l’innocenza di Beatrice. Filippo, Agnese e i Giudici smarriscono le loro certezze e, all’atto di firmare la sentenza, il duca di Milano esita, preda di sensi di colpa. Quando però apprende che la fazione devota a Facino Cane è armata e chiede di Beatrice, egli firma risolutamente la sentenza di morte. Beatrice, che continua a negare ogni colpa anche sotto tortura, accetta umilmente la propria ingiusta sorte perdonando l’invidiosa Agnese, mentre Orombello perdona i suoi nemici politici. Quindi la duchessa si incammina verso il patibolo, sostenuta dalla commossa partecipazione del popolo.
Da notare come nell’Ottocento si confondeva erroneamente Beatrice Cane nata a Tenda con Beatrice di Tenda ritenuta figlia del conte di Tenda Pietro Lascaris e di donna Poligena. Quella di Beatrice Cane resta una triste storia di femminicidio che trovò una lunga tradizione che perdura fino ai nostri giorni.