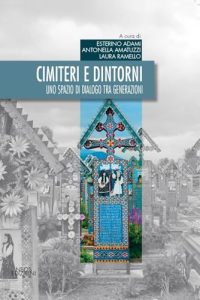Un agile volumetto, an-che se non recentissimo, (Cimiteri e dintorni. Uno spazio di dialogo tra generazioni, a cura di E. Adami, A. Amatuzzi e L. Ramello, Neos edizioni, Torino, 2023) risulta un ottimo strumento per comprendere come sia cambiata nel tempo l’immagine che abbiamo del cimitero.
Partendo dal significato originario del termine, “luogo di riposo”, nel quale noi onoriamo e rendiamo omaggio ai nostri cari che ci hanno lasciati e che, ovviamente, rimane intatto in tutto il suo valore, il testo ci guida a cogliere altri aspetti che tali luoghi sono in grado di rivelarci: dall’aspetto artistico che le lapidi e i monumenti funerari ci rimandano, alle informazioni in ambito linguistico e storico-culturale che si possono desumere dalle scritte presenti sulle lapidi stesse, contribuendo altresì, per esempio, a riportare alla luce la vita e le opere di personaggi un tempo famosi e oggi completamente dimenticati (si veda al riguardo la parte del volume dedicata al progetto “Sottovoce” relativo al Cimitero Monumentale di Torino).
Ecco così scorrere i numerosi esempi che analizzano queste tematiche in contesti molto diversi tra loro: oltre al già citato Cimitero Monumentale di Torino, il cimitero di Fiorentino a Fiorano, i cimiteri di Picpus e di Carnot de Suresnes in Francia e il cimitero La Certosa di Bologna, solo per citarne alcuni. Significativa attenzione viene dedicata, con ben due saggi, proprio al cimitero posto sulla collina di Fiorentino a Fiorano: il saggio che apre il volume è della Prof.ssa Maria Paola Capra, attuale vicesindaco di Banchette, che per prima portò alla ribalta questo piccolo gioiello con il suo volume “Fiorano, dalla collina di Fiorentino”, pubblicato nel 2005, e che presenta il progetto che l’autrice portò avanti con i suoi studenti della Scuola Media Sandro Pertini di Banchette per, come recita il sottotitolo del suo intervento, “Insegnare la storia passeggiando tra le lapidi dell’antico cimitero di Fiorentino”.
Il secondo saggio, di Sofia Tinetti, illustra i risultati di una accurata indagine socio linguistica fatta partendo dagli epitaffi presenti sulle lapidi del cimitero, oltre ad un breve riassunto della sua storia, così come emerge dal volume della prof.ssa Capra, prima citato, e che permette di aprire un interessantissimo squarcio su oltre cento anni di storia locale e non solo. Il cimitero di Fiorano, ad inizio ‘800, era collocato nei pressi della Chiesa, ad una distanza “di pochi trabucchi” (un trabucco equivale a circa 3,08 metri) e, teoricamente, in base all’editto di Saint Cloud del 12 giugno 1804, che prevedeva, tra l’altro, che i cimiteri dovessero essere posti al di fuori dei centri abitati, avrebbe dovuto essere ricollocato.
Ma si sa che Fiorano non era propriamente un grande centro, quindi sottoposto al solerte controllo delle autorità, motivo per cui fino al 1831 nulla accadde e si continuò a seppellire i morti nel cimitero vicino alla Chiesa. La Prof.ssa Capra ci ricorda che a sbloccare la situazione, quasi certamente, non fu neanche la circolare emanata dall’Ufficio di Regia Intendenza di Torino nell’ottobre del 1831, nella quale si ribadiva che i cimiteri posti nei centri abitati non erano più in regola ma, più probabilmente, un’epidemia che portò alla morte in breve tempo di 42 persone, con conseguente difficoltà a reperire uno spazio sufficiente per le sepolture: il dato certo è che a quel puto il Consiglio comunale sentì la necessità inderogabile di realizzare un sito lontano dal centro abitato.
L’individuazione dell’area in cui far sorgere il nuovo cimitero non fu semplice e al perito Carlo Bodojra venne affidato l’incarico di analizzare le diverse opzioni. La scelta parve cadere su un appezzamento della Parrocchia in regione Duera, con l’aggiunta di cinque tavole (una tavola corrisponde a circa 38,1 m2) di proprietà di un certo Pistono Pietro, da utilizzare per la costruzione della strada di accesso. Nel febbraio del 1832 fu eseguito il progetto con relativo calcolo delle spese da sostenere.
Non ci sono notizie sui motivi che portarono poi ad abbandonare tale opzione con la scelta della collina di Fiorentino quale sede del nuovo cimitero anche se, certamente, come ricorda la Prof.ssa Capra, un ruolo non secondario lo giocò il fatto che lì ci fosse un terreno, con una estensione di circa 50 tavole, già di proprietà del Comune, che quindi portava ad un abbattimento dei costi di realizzazione dell’opera. Il Consiglio approvò tale proposta il 14 aprile del 1832 ottenendo il beneplacito del parroco, don Rigoletti, il 6 maggio successivo.
Le spese previste ammontavano a 4166,61 lire e, vista l’entità della cifra, i lavori vennero suddivisi in quattro lotti. Risultarono conclusi al 17 luglio 1834 le opere di costruzione del cimitero, della piazzetta antistante la Chiesa, e di una parte della strada che conduceva al cimitero stesso. Bisognerà aspettare l’estate del 1840 per vedere definitivamente realizzato il progetto iniziale. Ci si rese ben presto conto, però, che anche il nuovo cimitero era troppo piccolo e che quindi la scelta, fatta per motivi economici, di utilizzare solamente 30 delle 50 tavole disponibili non era stata del tutto felice.
Questo risultò ancora più evidente quando, a seguito di una legge entrata in vigore nel 1887, si presentò la necessità di destinare una parte del cimitero ai non credenti o a fedeli di altre religioni: il Comune di Fiorano dovette riconoscere di non essere in grado di ottemperare a tale norma per mancanza di spazio. E così si avviò la lunga contrapposizione tra i sostenitori dell’ampliamento di Fiorentino e i fautori della costruzione di un nuovo cimitero, lungo la strada tra Fiorano e Loranzé.
Furono questi ultimi a spuntarla, ma siamo ormai nel 1931: l’ultima inumazione nel cimitero di Fiorentino avvenne nel febbraio di quell’anno; la prima sepoltura nel nuovo cimitero fu nel marzo successivo. E così cominciò il lento declino del sito. Poi ad inizio degli anni 2000 due fatti che porteranno ad una rivalutazione dal punto di vista culturale e dal punto di vista strutturale del cimitero.
La Scuola Media di Banchette aderisce al concorso organizzato da FAI e Corriere della Sera “L’arte e la natura in primo pagina” e la Prof.ssa Capra propone come monumento degno di essere salvato il cimitero di Fiorentino, portando così gli studenti, in collaborazione con gli anziani, “memoria storica” di Fiorano a ricostruire la vita e le opere dei sepolti a Fiorentino.
Quasi contemporaneamente ecco l’adesione del Comune di Fiorano al progetto “Percorsi tra fede e ragione” finanziato da Regione Piemonte e Unione Europea che ha permesso, tra le altre cose, il restauro ed il recupero del sito. Ciliegina sulla torta il già citato splendido volume della Prof.ssa Capra del 2005 che, come una novella antologia di Spoon River canavesana, ripercorre la storia del cimitero e ci presenta le vicende di quasi tutti coloro che lì sono sepolti: alcuni famosi, altri, la maggior parte, sconosciuti ma la cui vita permette di ricostruire uno spaccato che ci aiuta a comprendere anche pagine significative della grande Storia.
Oggi il cimitero, perfettamente conservato grazie anche all’opera dei volontari, è facilmente visitabile e chiunque può varcare il cancello posto all’ingresso e immergersi in un luogo che lo proietta in un tempo lontano, avendo di fronte un panorama veramente mozzafiato che spazia dal Mombarone alla Cavallaria, fino ai confini dell’Anfiteatro morenico di Ivrea che sembrano appoggiarsi sui tetti delle case del sottostante Fiorano.